Elaborato di Giulia Ciancaglini
Ecco per quale motivo i migranti hanno meno possibilità di evitare che un’epatite virale si trasformi in malattia cronica del fegato. E perché soltanto un serio investimento nella prevenzione può abbattere la sua diffusione e quindi il costo delle cure.
La cirrosi è una malattia insidiosa. Come molte altre patologie epatiche, è trascurata dai pazienti anche se può portare alla morte. Per calcolare il tasso di mortalità di una malattia, gli scienziati e i medici usano diversi metodi. Uno di questi, tra gli “end points”, calcola gli anni di vita persi dalla popolazione. A incidere su questo calcolo, il numero delle persone che soffrono di una patologia e l’età in cui muoiono. Le malattie epatiche registrano 190 anni di vita persi su 100.000 abitanti. Per l’Hiv, prendendo lo stesso campione, il tempo perso è poco più di un quarto: 50 anni di vita.
Il tasso di mortalità è legato alla cronicità della cirrosi: nell’organo si forma un tessuto fibroso che ne limita le funzionalità e questa è una condizione per lo più irreversibile. Eppure, per diagnosticare una disfunzione del fegato spesso bastano analisi del sangue generali, accompagnate da analisi sierologiche specifiche, che servono per ricercare anticorpi contro virus che causano epatite.
La maggior parte delle malattie epatiche sono difficili da riconoscere per il paziente: l’insidia delle epatiti virali è tutta nei sintomi, molto vaghi e facili da confondere con quelli di altre malattie, magari banali, come l’influenza. Dolore addominale, diarrea e vomito sono i più diffusi.
La cirrosi epatica è il più grande fattore di rischio per il tumore più frequente del fegato: il carcinoma epatico. Ed ecco come le altre malattie del fegato – le epatiti e le neoplasie – sono in qualche modo collegate alla cirrosi. Le prime possono rappresentare la fase precedente, le seconde la successiva.
Cirrosi, nel nostro immaginario, fa rima con alcolismo. Ma questa convinzione può risultare prevenuta e, soprattutto, incompleta. Sicuramente l’uso e l’abuso di alcool è un grande fattore di rischio ma le probabilità di ammalarsi di cirrosi possono essere abbattute seguendo un’alimentazione sana, mantenendo un peso nella norma e riducendo il rischio di contrarre l’epatite B o C, con rapporti sessuali protetti e – quando possibile – con vaccinazioni. Per ridurre il rischio di arrivare allo stadio cirrotico, insomma, bisogna essere nelle condizioni di mangiare sano e di avere un controllo sulla propria situazione sanitaria.
Come spesso accade, è la combinazione di corrette abitudini a fare la differenza nella prevenzione. Mangiare bene, non bere troppo alcool, vaccinarsi, avere rapporti sessuali protetti. Ecco la formula per ridurre i rischi. Alcune persone, però, non possono scegliere come e quando mangiare perché vivono il dramma della fame. E non hanno il vaccino contro l’epatite perché, nel paese dove sono nati e da dove scappano, quello strumento di prevenzione primaria non è ancora arrivato. Sono i più fragili, i rifugiati.
I numeri dei rifugiati
Lo scorso anno, il 2019, ha segnato un (triste) record: secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr) a trovarsi nella condizione di dover lasciare la propria casa in fuga da guerre, persecuzioni, calamità naturali sono state circa 71 milioni di persone. Il numero non è mai stato così alto. E quando si scappa dalla propria casa, difficilmente si mangia sano e si pensa al vaccino contro l’epatite.
Come si legge nel report del Centro Astalli, la popolazione afgana fugge da violenze e conflitti da oltre quarant’anni, nonostante la comunità internazionale continui a parlare di un Paese pacificato. In Yemen, dopo cinque anni di guerra, più di 3,6 milioni di civili hanno lasciato le proprie case. In Africa, soltanto dal Sud Sudan, oltre 2 milioni di persone sono state costrette a mettersi in cammino. Ma la crisi migratoria più vasta rimane quella siriana che, entrata nel suo decimo anno di guerra, ha causato la fuga di oltre 5,5 milioni di persone, mentre sono più di 6 milioni gli sfollati interni che vivono in condizioni di estrema povertà.
Se il 2019 avesse un nome, si chiamerebbe “l’anno delle vite sospese”. Migliaia di migranti hanno vissuto una sorta di limbo. Dimenticati nelle carceri libiche, nei campi profughi delle isole greche o persino sulle navi che li hanno soccorsi, lasciati in balìa delle onde per giorni.
Soltanto 11.471 migranti sono approdati in Italia (facendo registrare un calo di oltre il 50% rispetto al 2018 e del 90% in relazione al 2017). Chi è riuscito ad arrivare nel nostro paese ha subìto le conseguenze dei due decreti sicurezza convertiti in legge dal Parlamento che sono intervenuti sulla natura dei permessi di soggiorno, abolendo la protezione umanitaria, e sull’accoglienza, riducendo drasticamente i servizi previsti per i richiedenti asilo.
Il percorso d’integrazione del Centro Astalli
In Italia, queste modifiche legislative hanno interrotto o inasprito i percorsi di integrazione, pensati e costruiti da realtà di volontariato come il Centro Astalli, che da circa 40 anni ha l’obiettivo di difendere i diritti dei rifugiati. Il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati — JRS, di cui il Centro Astalli è la sede italiana, tra le numerose definizioni, adotta quella di “rifugiato de facto” che comprende tutte le persone perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e politico e le vittime di conflitti armati, di politica economica errata o di disastri naturali.
Tra i servizi che offre — come la mensa, il centro di ascolto e orientamento socio-legale, la scuola di inclusione — ci sono anche l’ambulatorio e il centro SaMiFo: due luoghi dove i migranti possono essere visitati e curati.
Il primo, aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a Roma nei locali della mensa, è un punto di riferimento cui rivolgersi per incontrare un medico e avere informazioni sul sistema sanitario italiano. Lo scorso anno, 1.485 migranti si sono rivolti all’ambulatorio, per un totale di 2.384 visite. Nel 2019 molti rifugiati cui è stata impedita o cancellata l’iscrizione al Servizio sanitario regionale a causa dell’inasprimento delle normative sono andati all’ambulatorio: soltanto il 31% degli utenti era in possesso della tessera sanitaria. I pazienti per l’89% sono uomini, anche se si registra un aumento (+3%) delle pazienti donne, dato in linea con l’aumento delle presenze di migranti somale e nigeriane.
Per le donne, spesso è difficile immaginare di essere prese in considerazione e aiutate. Le parole di Sussy, una rifugiata dal Camerun, ne sono una testimonianza: “Non ho scelto di venire in Italia. Dovevo scappare, la mia vita e quella di mia figlia erano in pericolo. Una volta arrivata a Roma mi hanno indicato di andare alla stazione Termini lì avrei trovato qualcuno che parlava la mia lingua e mi avrebbe aiutato. Ho vagato tanto tempo nella stazione fino a quando un signore mi si è avvicinato e mi ha detto vai a via degli Astalli, lì puoi mangiare e farti una doccia. Poi chiedi di parlare con un medico e un avvocato. Sono arrivata alla mensa alle due del pomeriggio, fuori c’era una fila lunghissima di uomini. Saranno stati più di 300. Mi sono avvicinata alla porta e mi sono presentata. Mi hanno fatto passare avanti a tutti. Ero molto sorpresa poi mi hanno spiegato che le donne e i bambini non fanno la fila, entrano prima degli uomini. Da questo ho capito che ero finalmente al sicuro. Le donne in Camerun non verrebbero mai prima degli uomini. Anzi!”.
Il centro SaMiFo, dove accoglienza fa rima con presenza
Alcune realtà più di altre riescono a diventare, con il tempo, una presenza costante nella vita dei migranti in difficoltà. Il centro SaMiFo — centro per la Salute dei Migranti Forzati — è una di queste. Nato nel 2006 con un protocollo d’intesa tra la ASL Roma 1 e il Centro Astalli, segue nell’assistenza sanitaria i rifugiati che arrivano nella capitale.
Lì, vicino Piazza Vittorio, lavorano operatori sanitari generici e specialistici, aiutati da un gruppo di operatori e mediatori linguistico-culturali che operano allo sportello di accoglienza e supportano il personale sanitario durante le visite per rendere efficace la comunicazione tra medici e pazienti.
Per questo motivo, se chiami il SaMiFo può succedere che, prima di ascoltare le tue esigenze, ti mettano in attesa e dalla cornetta del telefono si senta la voce di una mediatrice che parla lingue con un suono che non hai mai sentito, come il cinese o l’africano.
All’ambulatorio fanno le prime analisi, ma subito dopo i pazienti vengono presi in carico sul lungo periodo dal centro SaMiFo, dove possono trovare aiuto i migranti con problematiche fisiche e psichiche dovute a traumi subiti nei Paesi di origine o durante il viaggio, ma anche legate alla precarietà della vita in Italia. Durante l’anno il SaMiFo ha assistito 1.814 pazienti, il 42% dei quali si è rivolto al servizio per la prima volta, registrando 3.826 visite nel reparto di medicina generale.
Al SaMiFo lavorano due dottori che assumono per i rifugiati il ruolo di medico di famiglia. Uno si chiama Antonio Spina, lavora lì da quindici anni, e racconta: “Noi facciamo il possibile per essere presenti per loro, abbiamo una rete di specialisti all’interno della Asl che ci aiuta, ma comunque li vediamo tutti i giorni. La stragrande maggioranza dei nostri pazienti riesce a fare le terapie e i controlli nel tempo giusto”.
Nel 2019 è stato realizzato anche un documentario, dal titolo Reaching Terminus: vignettes of refugee daily life in Rome. Si tratta di un lungometraggio realizzato dal regista Nour Gharbi in cui, attraverso il racconto delle storie e le testimonianze di tre rifugiati assistiti, si descrive proprio il SaMiFo. Immortala complessità e sfide del lavoro che medici, operatori sociali e volontari svolgono ogni giorno per accompagnare, in un percorso di riabilitazione medica e psico-sociale, i migranti forzati verso una nuova vita in Italia. Infatti, circa il 35% dei pazienti del centro sono risultati vittime di tortura o maltrattamenti, di tratta, di mutilazioni genitali femminili e portatori di disturbi post-traumatici.
La vaccinazione e l’educazione mancata
Una malattia insidiosa come la cirrosi, che ha bisogno di continui controlli per essere diagnostica, è forse l’ultimo dei problemi per le persone che vivono situazioni sanitarie al limite. Ma può essere anche mortale, soprattutto per le persone che non hanno accesso allo strumento primario di prevenzione: il vaccino.
L’epatite B si previene con la vaccinazione, obbligatoria in Italia, che conferisce un’immunità a lungo termine e viene somministrata di solito in tre dosi. Sangue, liquido seminale e secrezioni vaginali: questi flussi corporei sono i veicoli del virus. Quindi rapporti sessuali non protetti, condivisione di rasoi e spazzolini da denti o di siringhe che dovrebbero essere monouso sono le cause più frequenti di contagio.
Viene diagnosticata con un prelievo del sangue e relativo test, che però deve essere specificamente richiesto, perché i comuni esami del sangue, spesso prescritti dal medico curante in caso di sintomi aspecifici come in questi casi, non permettono di riconoscere il problema. La malattia può essere cronica nelle persone che provengono da quelle aree del mondo in cui il virus HBV è endemico — cioè diffuso nel territorio stabilmente da tempo — come Centro e Sud-est asiatico, Africa, Est Europa.
Questo tipo di epatite può anche essere trasmessa dalla madre al nascituro durante il parto: i bambini immigrati da tali aree possono aver contratto l’infezione alla nascita. L’epatite D è un altro virus che infetta il fegato e può portare a cirrosi epatica, ma si verifica soltanto nelle persone già infette da epatite B.
“Qui arrivano molti migranti con le epatiti che rischiano la cirrosi — racconta Antonio Spina, medico di base del SaMiFo — ma sono pochi quelli che hanno già la cirrosi. Su cento pazienti con l’epatite, soltanto uno o due hanno la cirrosi. E sono arrivati già con la malattia cronica qui da noi”. La giovane età media dei rifugiati e la prontezza nelle cure da parte del centro incidono su questo dato. “Sempre, la prima volta che vediamo un paziente nuovo, facciamo le analisi del sangue di primo livello e, se ha gli anticorpi per i virus, richiediamo anche l’esame specifico che ci informa sulla carica virale”, spiega il dottore.
L’epatite C, causata dal virus HCV, si può trasmettere soltanto per il contatto diretto con il sangue infetto, non esistono vaccini per prevenirla, molto spesso è asintomatica ed è ancora più complicata da debellare. Solo il 30% circa delle persone infettate da HCV sono in grado di sconfiggere il virus grazie al proprio sistema immunitario e ciò accade nel giro di circa sei mesi. Il restante 70% dei pazienti non si libera mai del virus e sviluppa una malattia cronica. L’unico vero modo per prevenire il contagio da epatite C, che a lungo termine può portare a malattie epatiche fatali come la cirrosi e il tumore, è evitare le fonti di rischio.
Ma per evitarle, bisogna conoscerle e anche l’educazione alla prevenzione è un lusso che non tutti si possono permettere. Esistono paesi del mondo dove le informazioni sulle malattie non sono diffuse. Nei territori più colpiti, dove le epatiti sono endemiche, lo Stato è assente e le opere di sensibilizzazione e prevenzione vengono messe in campo quasi esclusivamente da Onlus e Ong internazionali ed europee.
Il costo della prevenzione e della convivenza con la malattia a tavola
Un’alimentazione povera di rado è la vera causa eziologica di una malattia al fegato. Nei territori dove si soffre la fame, come l’Africa, l’epatite B è un virus endemico, quindi è più probabile essere contagiati a livello virale che ammalarsi per quello che (non) si mangia.
Antonio Spina ha confermato questa tendenza: “Sulla base della mia esperienza, posso dire che questi problemi al fegato nei migranti possono derivare da farmaci, ma è più raro. Oltre il 90% dei casi è di origine virale. Ricordo soltanto un caso in quindici anni di cirrosi alcolica, non è il nostro target di pazienti”.
Mantenere un peso forma ideale è però una delle abitudini di prevenzione consigliate per tutte le malattie epatiche e a tutti i cirrotici, dopo la diagnosi, viene indicata un’alimentazione particolare. L’approccio generale consiste nell’adottare una dieta sana, varia ed equilibrata, se possibile studiata con l’aiuto di un dietologo, ma soprattutto che venga adeguata periodicamente in base all’evoluzione della cirrosi. Queste attenzioni, sia in fase di prevenzione che di convivenza con la malattia, hanno un costo che i migranti non possono permettersi. E che lo Stato non assicura, così come non garantisce l’assistenza sanitaria necessaria.
L’assistenza sanitaria saltuaria per malattie croniche
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Così si legge nell’articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana. “Individuo” qui significa “tutti”, cittadini italiani ma anche migranti, a prescindere dalla loro regolarità. Nel 1995, per aumentare la tutela di questo diritto, è stata firmata una legge per la quale non può essere il medico a denunciare un migrante irregolare.
Quando uno straniero sbarca in Italia, viene immediatamente inviato a un centro di primo soccorso e assistenza, detto hotspot. Qui la persona resta poche ore, il tempo di essere identificata e valutare se ha diritto o meno. Se la persona non fa richiesta di protezione internazionale, viene inviata al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), in cui si cerca di capire da dove viene e si procede con l’espulsione. Se, al contrario, viene ritenuta avente diritto, è inviata in un Centro di prima accoglienza (Hub), dove resta per un massimo di 30 giorni e riceve una visita medica effettiva. Da lì gli stranieri vengono poi smistati nelle varie strutture di accoglienza.
Spesso si riconosce un altro tipo di assistenza agli stranieri detti Soggetti Temporaneamente Presenti (Stp): a ogni persona viene associato un codice alfanumerico che gli consente di accedere ai servizi sanitari. Questa formula è gratuita, dura 6 mesi ed è rinnovabile. Un altro tipo di carta, rilasciata a stranieri a vario titolo, è l’Eni (Europeo Non Iscrivibile) pensata per comunitari che non hanno la Team, cioè la tessera sanitaria.
La differenza tra uno straniero Stp e un cittadino è che, mente il Sistema garantisce al cittadino le prestazioni più semplici, passando via via alle più complesse, per lo straniero è il contrario: la garanzia va dagli interventi più urgenti a quelli meno urgenti. Prima del testo unico del ’98 le cure si limitavano addirittura a risolvere l’urgenza, senza poi avere una continuità. In pratica i malati vengono curati soltanto quando stanno male e non vengono assistiti nel tempo.
“Per evitare che un’epatite si trasformi in cirrosi c’è bisogno di una continua assistenza, mentre quando la cirrosi si è già instaurata, purtroppo, richiede molti trattamenti di tipo medico e chirurgico — racconta il medico di famiglia del SaMiFo — Noi lavoriamo perché l’epatite non si trasformi mai in cirrosi. La cura delle forme virali di epatiti è molto lunga e i protocolli non prevedono terapie inferiori a sei mesi”.
In medicina si usa il termine “outcome” per indicare il risultato delle terapie effettuate sul paziente per farlo tornare allo stato di guarigione. Un outcome è favorevole quando il paziente torna a essere sano, superando la patologia, o sfavorevole quando la patologia è grave e non è stata possibile una sua cura completa. Grazie a questo indicatore, per esempio, si possono comprendere alcune grandi disuguaglianze: i dati sugli outcome degli ospedali del Nord Italia confrontati con quelli del Mezzogiorno esprimono lo scarto in termini di efficienza sanitaria.
In generale, i pazienti affetti da malattie croniche, come la cirrosi, rischiano di avere outcome negativi. Guardando questi numeri però emerge una fotografia: molto spesso il paziente cirrotico — ancora più se straniero — viene assistito soltanto quando ha delle complicazioni che comportano una fase acuta anche se una malattia cronica si riconosce per il lento e progressivo declino delle normali funzioni fisiologiche.
“Noi abbiamo tanti pazienti che sono positivi all’epatite B e C ma che hanno una carica virale bassa, insufficiente a determinare poi una trasformazione in cirrosi. Loro non necessitano di trattamenti farmacologici immediati ma di controlli nel tempo, ogni 3–6 mesi”, spiega il dottor Spina.
Proprio per questo, chi ha un’epatite che rischia di sfociare in cirrosi dovrebbe essere seguito non soltanto da un medico ma anche da un infermiere e un assistente sociale. Il medico di base responsabile dovrebbe monitorare costantemente la situazione e prescrivere, a seconda dei casi, farmaci per il trattamento dell’epatite o di altre malattie sottostanti la cirrosi, integratori per ridurre i sintomi della cirrosi, antibiotici per contrastare infezioni in corso, o programmare interventi chirurgici per ridurre la pressione sanguigna nel fegato o per fermare eventuali emorragie, fino al trapianto di fegato. Ma questo costante monitoraggio non sempre, e non per tutti, viene attuato.
Un male e un prezzo per tutti
Nonostante i farmaci contro l’epatite virale, ancora oggi in Italia circa 200mila persone convivono con la cirrosi epatica e di questi ogni anno circa l’8% muore a causa di questa malattia. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, la Cirrosi rappresenta l’ottava causa di morte, con una mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni.
Negli individui che presentano cirrosi, circa il 30–45% mostra segni di una encefalopatia conclamata, condizione a cui si giunge quando la compromissione del fegato è così importante da influire in maniera negativa sulle funzioni cerebrali. In pratica, quando un fegato diventa cirrotico il sangue, che dovrebbe essere ripulito da questo organo, giunge al cervello tramite rami collaterali. Il fegato quindi non può svolgere la sua funzione di filtro e, così, sostanze dannose arrivano al cervello.
La prima fase dell’encefalopatia epaticaè caratterizzata da un ritmo di sonno-veglia invertito per cui si è portati a dormire di giorno e a rimanere svegli la notte. La seconda fase invece comporta agitazione psico-motoria e confusione mentale. La terza provoca sonnolenza e sopore e la quarta, addirittura, la progressione verso il coma.
Secondo uno studio del Ceis dell’Università di Roma Tor Vergata, si calcola una spesa media per ogni paziente con encefalopatia epatica di oltre 11mila euro l’anno solo per ricoveri ospedalieri e si stima un costo complessivo nazionale di oltre 200milioni all’anno. La cirrosi epatica, con le sue complicazioni, non è soltanto una malattia insidiosa, ma anche costosa per lo Stato. Il prezzo delle cure, spesso fuori misura se si tratta di pazienti stranieri, è enorme anche per i cittadini italiani. In più, i servizi che questa malattia richiede sono numerosi e fanno la loro parte nell’ingolfare un sistema sanitario già con l’acqua alla gola, che oggi impiega soltanto il 5% dei fondi nella prevenzione. Proprio per questo, investire sulla sensibilizzazione rimane la soluzione più ragionevole sia a livello sanitario che economico.
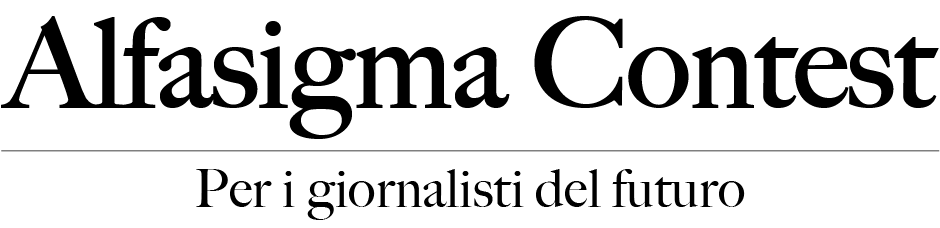
Commenti recenti